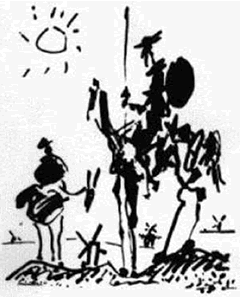 Una rivista romana ha proposto nove domande sul romanzo a un gruppo di scrittori. Per il momento non ci interessa studiare il senso delle risposte o, tanto meno, vedere se per caso non ci aiutano a fare qualche passo avanti nella complicata questione del romanzo. Quello che ci ha colpito leggendo le risposte all’ultima domanda: “Quali sono i romanzieri che preferite e perché?” è la particolare frequenza del nome di Cervantes. Tre di questi scrittori – e non dei minori – hanno tenuto a fissarlo come punto di riferimento e un quarto, alludendo al Don Chisciotte, ne riconosce sia pure indirettamente il valore di simbolo. Si tratta di una piacevole sorpresa, vuol dire che Cervantes è uscito da quella specie di limbo in cui i nostri scrittori lo avevano relegato per un numero di ragioni che non serve illustrare qui.
Una rivista romana ha proposto nove domande sul romanzo a un gruppo di scrittori. Per il momento non ci interessa studiare il senso delle risposte o, tanto meno, vedere se per caso non ci aiutano a fare qualche passo avanti nella complicata questione del romanzo. Quello che ci ha colpito leggendo le risposte all’ultima domanda: “Quali sono i romanzieri che preferite e perché?” è la particolare frequenza del nome di Cervantes. Tre di questi scrittori – e non dei minori – hanno tenuto a fissarlo come punto di riferimento e un quarto, alludendo al Don Chisciotte, ne riconosce sia pure indirettamente il valore di simbolo. Si tratta di una piacevole sorpresa, vuol dire che Cervantes è uscito da quella specie di limbo in cui i nostri scrittori lo avevano relegato per un numero di ragioni che non serve illustrare qui.
D’altra parte, il ricorso a Cervantes – un ricorso diretto e immediato com’è quello dei veri responsabili della vita letteraria – dovrebbe essere praticato come una consuetudine dell’intelligenza e – se il termine non urta – come una misura profilattica contro il pericolo delle mode, soprattutto contro l’abuso dell’intellettualismo a detrimento delle qualità istintive della fantasia e dell’amore della realtà. Una stagione, o per usare l’immagine concreta di Thomas Mann, una “traversata” con Don Chisciotte resta una profonda e intensa lezione di verità umana.
Il grande romanziere tedesco indicò l’opportunità di questo tipo di confronti, apparentemente liberi e divaganti, quando per la prima volta andò in America e il lettore italiano può trovare ora nella bella collana delle Silerchie di Alberto Mondadori la ristampa del saggio (Una traversata con Don Chisciotte, edizioni del Saggiatore). Non ci si aspetti di trovare indagini in profondità o conclusioni a proposito del capolavoro cervantino: no, ciò che conta è saper mettere a tono la lezione di Mann, vedere in che modo una esperienza di lettore possa innestarsi nel corso stesso della vita o, addirittura, fondersi con le ansie e le preoccupazioni dell’intelligenza. Il saggio, nato originariamente come una serie di corrispondenze giornalistiche per la “Neue Zürcher Zeitung”, a distanza di venticinque anni non ha perso gran che della sua efficacia.
Caso mai ci si potrebbe chiedere se la nostra civiltà o meglio le nostre nuove abitudini di vita consentirebbero ancora di queste divagazioni, di questi ozi preziosi, ma anche questa è una domanda da evitare: purtroppo siamo abituati diversamente e abbiamo bisogno di confronti immediati. Non crediamo più ai modelli eterni, i nostri eroi sono provvisori, fotografici e senza fondo. In altre parole siamo convinti che l’unica verità utile sia quella del momento e che tutto il resto faccia parte di un agio, di una ricchezza che ormai ci sono proibiti. Ma non è neppure di questo che dobbiamo occuparci: per il momento ci sembra più opportuno mettere l’accento su un altro fatto e, cioè, che la semplicità discorsiva di Mann finisce per toccare due punti vivi della questione Don Chisciotte, di solito sacrificati e annullati da un eccesso di intenzioni culturali, dal bisogno di trovare dei simboli e delle spiegazioni cervellotiche alla grande fantasia cervantina. Il caso limite di questa aberrazione si verificò proprio da noi qualche anno dopo l’apparizione del saggio manniano e per opera di un filologo inspiegabilmente smarritosi in una spaventosa selva parafilosofica: l’idea di spiegare le vicende di don Chisciotte con il sussidio di Sant’Agostino era un’idea come un’altra, ma in pratica non doveva servire che a darci un pensum illeggibile e inutile.
Purtroppo questa mania non si è spenta, se proprio in questi giorni arriva dalla Spagna la notizia che un letterato avrebbe trovato finalmente la chiave del capolavoro cervantino nella storia di Ignazio di Loyola: anche quando sarà pubblicata la tesi enorme di Rodrigo Valdés ho il sospetto che il mistero di Cervantes resterà per nostra fortuna intatto. Ha ragione da vendere Mark Van Doren nel suo libretto Don Quixote’s Profession (New York, Columbia University Press) quando, a proposito del mistero del libro, tiene a ripetere una cosa non nuova ma che un po’ tutti noi siamo portati fatalmente a trascurare. Dice il critico americano che nessun lettore del Don Chisciottelegge lo “stesso” libro, di qui la necessità dell’origine delle infinite teorie. In realtà tale prerogativa spetta a tutti i grandi libri che non si esauriscono nell’ambito di una esperienza personale, e si verifica tutte le volte che lo scrittore riesce a fare della propria storia una storia anonima, senza un volto preciso, anzi suscettibile di sciogliersi in cento altre sembianze. Van Doren studia assai bene il fenomeno della verosimiglianza umana di Don Chisciotte. Il personaggio vive e, se sì, in che modo?
È la domanda capitale su cui poggia tutta la costruzione dello scrittore e su cui dovrebbe regolarsi l’intelligenza del lettore: guai a porre dei limiti, suggerire riserve su questo punto, altrimenti si finisce per aprire la prima breccia al gioco dell’interpretazione, qualcosa come le scatole cinesi che si ripetono all’infinito.
Una volta ammessa la vita vera del personaggio cervantino, bisogna però chiedersi: come vive? Van Doren risponde: vive come un attore, come uno che deve rappresentare una parte. Ecco la professione di Don Chisciotte, essere l’attore della propria vita e ci suggerisce un’altra distinzione: sul piano dell’esistenza la sua professione è quella dell’attore, ma su quello della volontà esistenziale è quella del Cavaliere Errante.
Metterei l’accento sulla scelta della professione come segno di evasione: ognuno di noi tende a rappresentare una parte per evitare la responsabilità delle ultime domande. La definizione di Van Doren: “Un gentiluomo di cinquant’anni, che non avendo nulla da fare si inventa un’occupazione” vale per Don Chisciotte ma anche per noi. Caso mai la differenza sta altrove: Don Chisciotte non aveva da fare nulla, ma aveva una sua fede, noi abbiamo soltanto da fare. Qualunque cosa ci tiene il posto di fede. Tutta la vita resta dilaniata da questa contradizione in profondità e non a caso Thomas Mann, alla fine della navigazione, sogna Don Chisciotte, ma un Don Chisciotte diverso da quello famoso.
“Aveva baffi grossi e cespugliosi, la fronte alta e sfuggente e, sotto le sopraciglia dense, gli occhi grigi erano quasi ciechi. Non si presentò come Cavaliere dei Leoni, ma come Zarathustra.” Ma anche questo è un sogno da europeo, è una fantasia da intellettuale. Nietzsche ha trovato la soluzione della vita nel gorgo della pazzia, probabilmente la sua era un’avventura non più sostenibile nell’ambito di una vocazione umana. Al contrario la mania di Don Chisciotte resta per ogni lettore di buon senso un invito al concreto, alla realtà, e tanto Mann quanto Van Doren hanno ragione nel raccomandare di tenere il pedale sull’importanza dello spirito comico, sulla grossa vena di scienza umana che nutre e domina la storia del Cavaliere Errante.
Sono proprio le grosse contradizioni del libro, gli squilibri, i bruschi passaggi dal comico al compassato a renderci sicuri della profondità della visione umana del libro: siamo noi a essere sempre seri, Cervantes, dice ancora Van Doren, è allegro, superficiale, strano, come la vita stessa. La chiave vera del problema sta qui: come la vita stessa. Un libro si salva dalla letteratura quando restituisce questo suono inconfondibile, quando gode di queste straordinarie ed enormi contradizioni: in qualsiasi altro modo obbedisce soltanto a una moda e, nel giro di quella moda, muore.
Varrebbe la pena di ricordare una verità tanto semplice ai commentatori del Don Chisciotte, soprattutto a quelli che si servono del libro per dar prova di acutezza e di impegno. Non si tratta di spiegare il Don Chisciotte come una serie di piccoli problemi, ma di lasciarsi penetrare da quella scienza della vita, semplice fino ad apparire grossolana, che si basa sulla verità naturale, rifiutando i sofismi, gli abusi, l’errore dell’intelligenza.
“La Stampa”, 30 luglio 1959
