CARLO BO, Jacques Rivière, a cura di Massimo Raffaeli. Fondazione Carlo e Marise Bo/Raffaelli Editore, Rimini 2023 (Quaderni della Fondazione, Collana diretta da Carlo Maria Ossola, n. 8)
Jacques Rivière, il primo libro di Carlo Bo, uscito nel 1935 dalla casa editrice Morcelliana a Brescia, viene ora ripubblicato dall’editore Raffaelli a Rimini con una Introduzione di Massimo Raffaeli che presenta il volume spiegando oltre al personaggio di Rivière anche le caratteristiche di contenuto e di stile di questo testo di critica del giovane Bo: “La struttura del Rivière in retrospettiva si profila quale archetipo della futura saggistica, un modello senz’altro perfettibile e però inderogabile nella nativa compresenza di auscultazione e riflessione, di specchio e rifrazione, di alter ego e antagonista qui portati al color bianco della pura incandescenza” (p.9).
Jacques Rivière, nella sua breve vita (è morto nel 1925 a trentanove anni) è stato molto attivo. Partecipando alla prima guerra mondiale come anche il suo amico Alain-Fournier, autore del romanzo Il grande Meaulnes, che è morto nel 1914 in una delle prime battaglie di quella guerra, Rivière è stato quasi subito fatto prigioniero dalle truppe tedesche e ha dovuto passare quattro anni in prigionia in Germania, scrivendo in quel periodo sui tedeschi, non amati da lui, il volume L’Allemand. Souvenirs et réflexions d’un prisonnier de guerre, e il suo romanzo Aimée, entrambi testi usciti dopo il suo ritorno in Francia.
È stato un critico letterario molto importante, autore di saggi su scrittori francesi allora ancora da far conoscere come Baudelaire, Claudel, Gide, Mauriac, Valéry, Aragon e tanti altri. È entrato in amicizia con Marcel Proust e dopo la sua morte nel 1922 ha contribuito alla pubblicazione degli ultimi tre volumi di À la recherche du temps perdu, scrivendo poi anche un interessante saggio su Proust e Freud, pubblicato tra tanti altri testi solo dopo la sua morte da sua moglie Isabelle, sorella di Alain-Fournier. Rivière dal 1911 fino alla sua morte nel 1925 è stato prima segretario, poi dal 1919, dopo il suo ritorno dalla Germania, direttore della importante rivista “Nouvelle Revue Française” e per questo una figura centrale e molto attiva nella letteratura e nella critica letteraria della Francia degli anni ’20.
Raffaeli spiega con il volume su Rivière il metodo particolare del giovane Bo che unisce umiltà e cuore nell’affrontare le opere da presentare, caratterizza il suo metodo come “l’aprirsi della critica come autobiografia” (p.13) e colloca per Carlo Bo Jacques Rivière accanto a Renato Serra e Charles Augustin de Sainte-Beuve fra le figure importanti della letteratura europea.
Il testo di Carlo Bo che segue è diviso in sei capitoli che spiegano il metodo di Rivière nelle sue opere di critica ed è allo stesso tempo anche una prima dimostrazione del proprio metodo di ricerca e di critica che cerca di unire i testi della letteratura con la sua partecipazione personale. Così presenta in Rivière l’umiltà come importante sfondo della sua attività di letterato, illumina il rapporto dei suoi scritti con le opere di Alain-Fournier, illustra i saggi del suo volume Ètudes, dedica un capitolo ai critici contrari ai metodi di Rivière, un altro capitolo al suo romanzo Aimée e finisce la sua presentazione
con il rapporto di Rivière con la religione e con l’opera di Proust.
(Ursula Vogt)
================================================================

================================================================

Per informazioni:
================================================================
In ricordo di Giovanni Bogliolo che ci ha lasciato il 30 ottobre 2019.
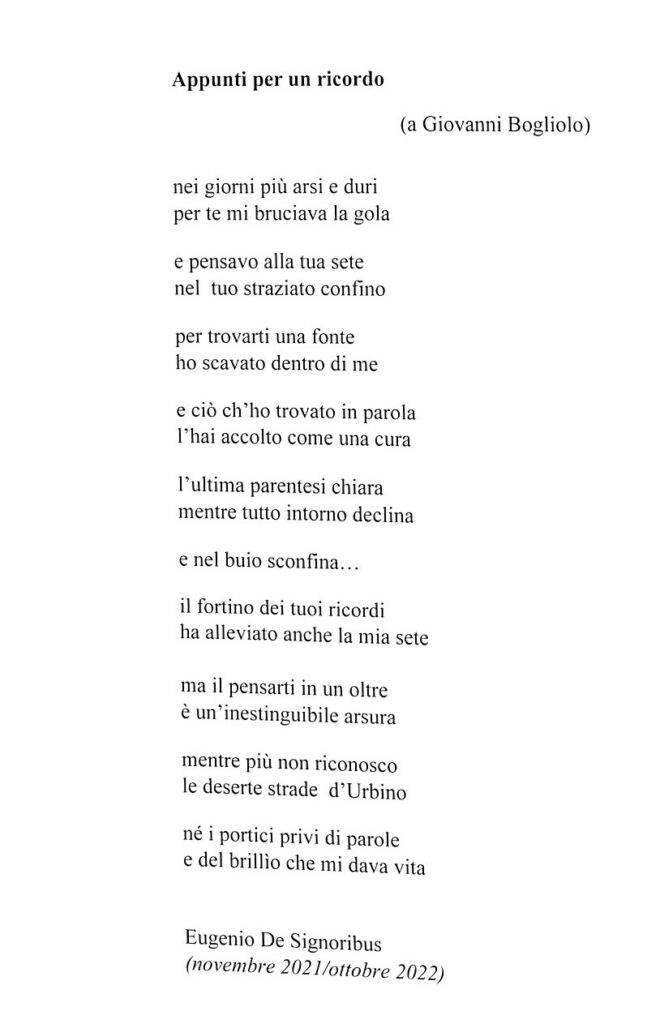
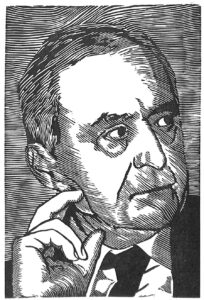
Poesia di Eugenio De Signoribus e xilografia di Andrea Gentili tratte da: Per Giovanni Bogliolo, Associazione culturale La Luna, Fermo, 2022 (consultabile in Biblioteca Bo).
================================================================
In ricordo di Silvia Cuppini, della sua generosa amicizia per la Fondazione Bo e per il suo Ateneo.
Tratto da: Presentazione del catalogo “Carlo Bo, il Palazzo Ducale. Parole e Immagini nelle stanze” Urbino, 22 giugno 2021
================================================================
Nel centenario della sua nascita (5 marzo 1922), ricordiamo Pier Paolo Pasolini con un un contributo emozionato scritto da Carlo Bo per la rivista «Nuova Antologia», in occasione della sua tragica morte (2 novembre 1975):
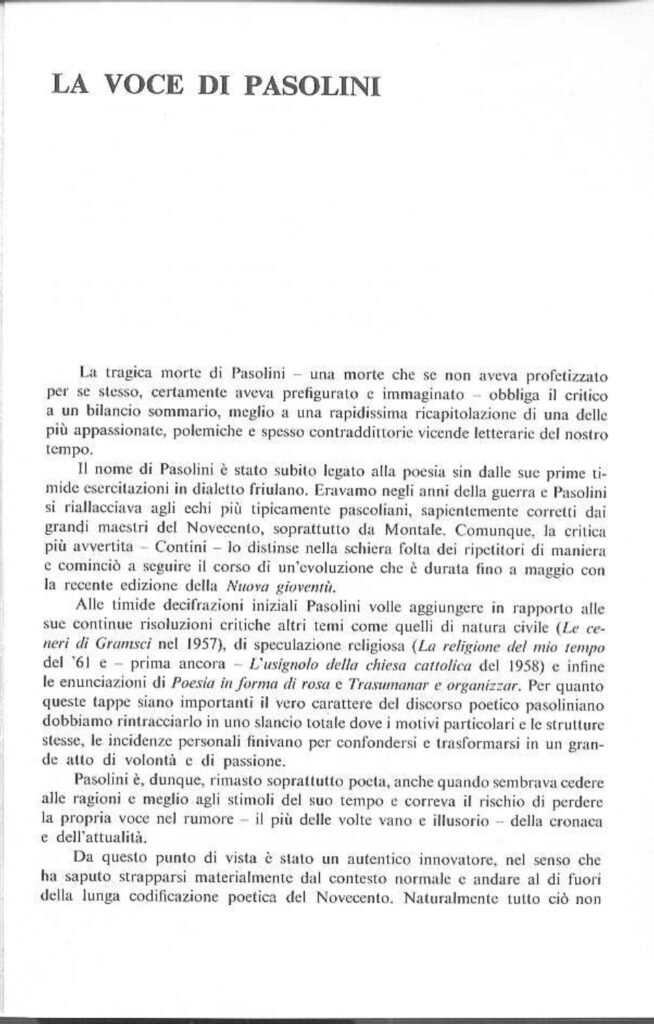
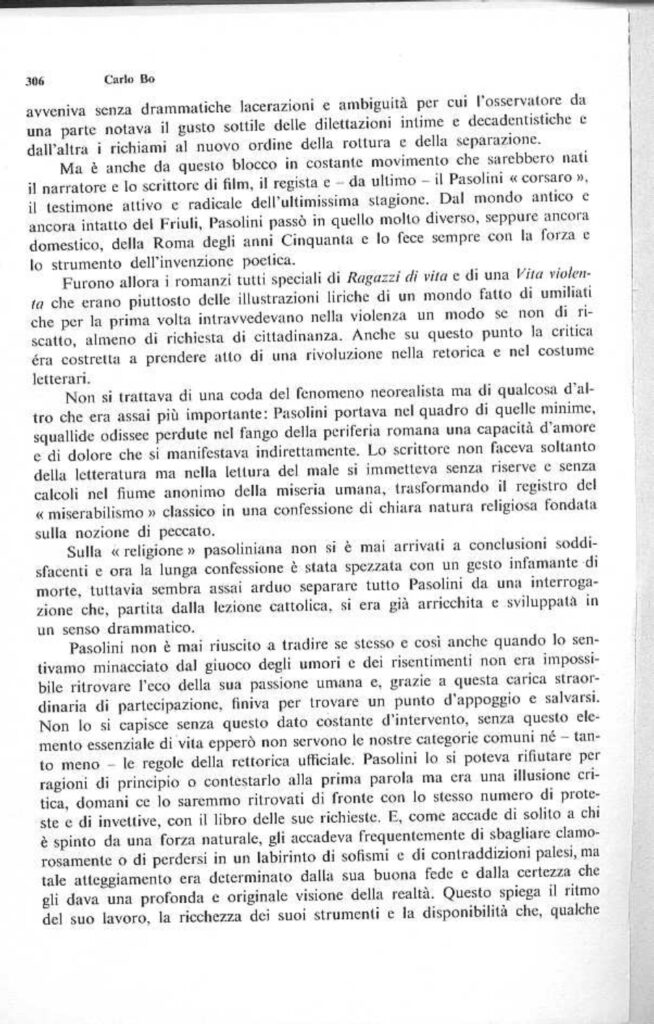
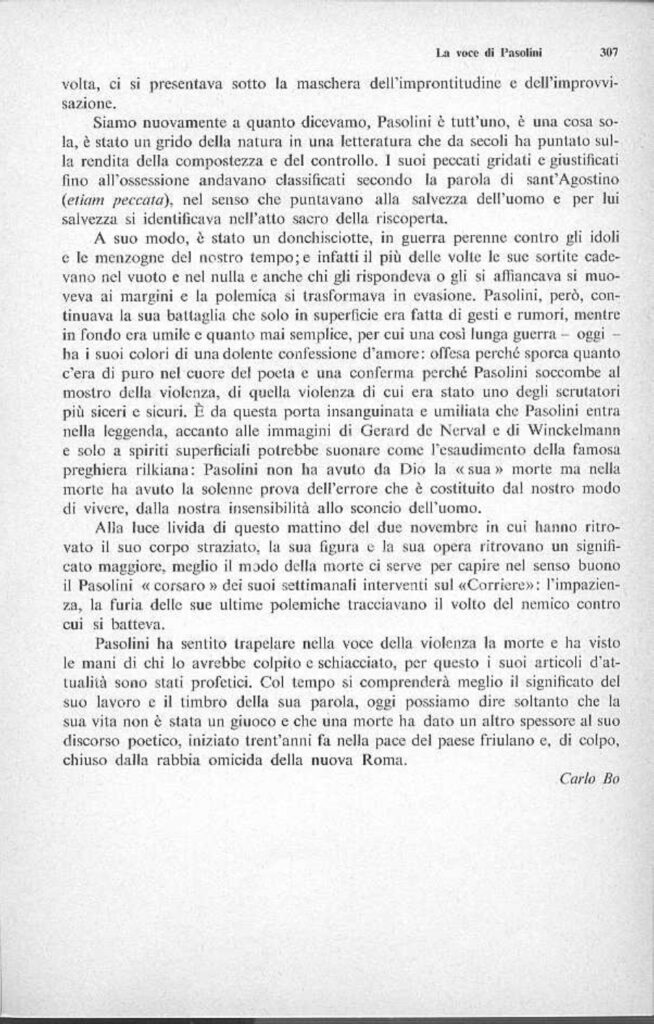
================================================================
In occasione dei 111 anni dalla nascita di Carlo Bo (era nato il 25 gennaio 1911), pubblichiamo il ricordo di Eugenio De Signoribus contenuto in Per Carlo Bo (Associazione Culturale La Luna, Fermo, 2022):
Eugenio De Signoribus, Un aspetto della grande anima
Dell’Opera di Carlo Bo, molti hanno scritto e scrivono, molti hanno parlato e parlano. Né posso aggiungere qualcosa. Ora posso solo sottolineare un aspetto della sua umanità.
Nel 1991, per le Edizioni Scheiwiller, uscì un libro di poesie di Roberto Rebora: “Fra poco”, “con una confessione di Carlo Bo”. Proprio così: non una prefazione ma “una confessione”, dichiarata già sotto il titolo, senza possibilità di equi- voci, in forma di lettera. Sarebbe bello e utile, per quelli che vivono fuori dalla vanità dei tempi, riproporla per intero. Sarebbe una consolazione. Ma ne riporto un passaggio:
“Caro Roberto, (…) devo dire subito che si tratterà di una confessione non facile, spesso dolorosa perché piena di rimorsi. Un critico commette i suoi errori maggiori non già nell’ambito delle valutazioni ma in quello delle omissioni: ciò che sembra un peccato veniale in effetti si trasforma in peccato capitale. E uno di questi errori io l’ho commesso nei tuoi riguardi: la cosa è tanto più grave perché ero nelle condizioni migliori per guardare, sentire e giudicare uno che mi è stato accanto per oltre mezzo secolo. Devo ammettere che sono stato una vitti- ma del rumore comune, di averti cioè trascurato o perduto nella confusione dei giorni, nel giro delle mode, diciamo pure nel concerto di chi sembrava avere in mano la bacchetta del direttore d’orchestra. Né vale dirmi che un po’ di colpa l’hai anche tu per la purezza della tua vita, per non avere mai alzato la voce, per non avere mai fatto nessun segno verso i distratti, i sordi, verso chi, come me, avrebbe dovuto avere il dovere di risponderti (…), hai patito, sofferto e nello stesso tempo hai dimostrato che la poesia, quando esista, è la sola arma per respingere l’infame armata della desolazione e della disperazione. (…)”
Devo “confessare” che, quando lessi questa lettera pubblica, ho a stento trattenuto il pianto. Un tale sentimento, di regola si legge in morte dell’amico che non può più rispondere, neppure per dirti grazie. Di lodi post mortem è pieno il cielo stellato. Inusuale invece il coraggio di mettersi a nudo, di esprimere un fallimento di attenzione, di stima, di amore. Di chiedere perdono a chi vive ancora, appartato, non vociante, non richiedente.
Come a dire: il mio compito è scrivere, portare la pur piccola testimonianza della mia vita. Poi non sta a me sollevare il rumore dentro un ben più vasto rumore, per farmi notare che esisto. Carlo Bo ha accolto questa verità della purezza altrui, come una propria colpa, come una necessità di giustificazione. Grande è la ricchezza della sua anima, del suo sguardo interiore, della sua onestà intellettuale. Ce ne sarebbe bisogno in ogni tempo che si accavalla al tempo e che non fa respirare, non fa guardare la sofferenza muta che ti è davanti. A lui, questo pensiero “filiale” e fraterno: perché, se ci si sente “figli” per’ testimonianza di vita e differenza d ’età, si è ti fraterni sempre. Oltre gli anni, oltre la fine.
================================================================
Per ricordare Carlo Bo che è nato il 25 gennaio 1911, 110 anni fa, ristampiamo un testo che egli ha scritto nel 1965, in un periodo in cui era molto preoccupato per il futuro della città di Urbino, molto amata da lui. Sebbene nel frattempo sono stati eseguiti molti lavori di restauro sui palazzi e gli edifici della città, la preoccupazione per il futuro della città è di nuovo forte. Il destino di Urbino dipende tuttora dagli studenti dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e dai turisti di tutto il mondo che venivano per vedere la bellezza di questa città. Il discorso di Carlo Bo, fatto 56 anni fa, è di nuovo attuale.
CARLO BO
UNA CITTÀ CHE NON DEVE MORIRE
Siete mai stati a Urbino? È una domanda che presuppone una risposta negativa. E non mancano le scuse: Urbino è fuori mano, Urbino è isolata, è un nome. Urbino continua a rimanere una città morta. Lo è soprattutto per gli italiani, per chi invece dovrebbe costituire una ragione orgogliosa e un tema di ritorno, un tema eterno. Infatti, insieme a poche altre città italiane, Urbino è una città dell’anima.
Ma il libro delle proteste non deve essere chiuso a questo punto. Oggi si deve parlare anche delle conseguenze di questo stato di cose, perché Urbino sta conoscendo una seconda morte.
Urbino crolla, Urbino cade in rovina. Si tratta di un patrimonio ingente che per inerzia o per distrazione si lascia deperire, fino al punto di doverne prevedere a breve scadenza una serie di danni irreparabili.
La città ha reagito, una legge speciale è stata preannunciata, qualche lavoro intorno alle mura sotto il Palazzo Duca le è stato anche iniziato, ma sono palliativi trascurabili in confronto di quello che resta da fare con urgenza e su basi molto più vaste. Chiese, palazzi, lo stesso miracolo del Palazzo Ducale sono minacciati: è un elenco lungo e doloroso che si è depositato nei secoli e che oggi reclama a gran voce un intervento decisivo.
Naturalmente non bastano delle opere parziali, non basta recintare le chiese pericolanti: Urbino per la sua storia e per la sua straordinaria bellezza esige che il suo problema sia affrontato in modo globale. Non basta arrestare il movimento di corruzione aperta, non basta nascondere o velare i segni della sua rovina, bisogna trovare, nell’ambito di una opera intesa a interrompere questa corsa verso la polvere, verso i ruderi, le ragioni di una ripresa, di una vera e propria rinascita.
Sembra quasi, anzi è una ironia che tanto patrimonio, così prezioso per la storia dell’uomo, sia affidato alle mai, anche se eccezionalmente esperte, di un solo scalpellino. Gli occorrerebbe un secolo di lavoro ininterrotto per sfiorare appena le opere più urgenti.
Di che cosa vive Urbino, che cosa – meglio – oggi le permette di non morire anche sul piano economico? Non già l’agricoltura che qui è sempre stata povera e oggi attraversa una crisi di carattere generale in condizioni di netta inferiorità. Le campagne si spopolano, famiglie che occupavano da secoli i poderi fuggono verso il mare, in cerca di un minimo di benessere e per rompere le catene di una durissima fatica. Urbino ha come uniche sue possibilità di salvezza, come elementi attivi per sopravvivere, l’arrivo degli studenti e il passaggio dei turisti.
Soltanto quando ci sono gli studenti Urbino sembra respirare e allontanare lo spettro della più desolata solitudine. L’Università conta oggi ottomila studenti, è in qualche modo la città vera. Qui come in nessun altro luogo del mondo la popolazione studentesca supera quella degli abitanti. A ogni urbinate corrisponde uno studente e mezzo. Si tratta quindi si sviluppare e di accrescere questa sorgente di vita, questa straordinaria occasione di sangue nuovo, potenziando le istituzioni che esistono da secoli e creandone altre. È quasi un simbolo che vale oltre la storia di una mirabile città, è un simbolo che serve per tutto il nostro Paese. Questa collaborazione spontanea fra una città monumentale e una popolazione di giovani lasci a intendere in che modo si deve pensare alla cultura. La cultura ambientata in città come Urbino è veramente il segno della continuità e di una speranza che possa vincere lo spettro della morte.
Urbino consente ciò che altrove , per esempio in una grande città, è impossibile: un dialogo, una vita in comune, la collaborazione naturale e spontanea fra studenti e professori. È questa gioventù a portare l’immagine di un futuro diverso, migliore.
Sono i giovani che oggi vengono da tutte le parti d’Italia e, d’estate, da tutta l’Europa, sono i giovani che danno il segno della possibile rinascita.
Si tratta quindi di offrire sempre di più a queste nuove famiglie di giovani umili ma veri, poveri ma certi e sicuri della loro passione intellettuale un soggiorno pieno, l’immagine completa di una dimora.
Non siete mai venuti a Urbino? Se continuerete a rispondere di no, dovrete sentirvi in colpa, perché vi mancherà una dimensione della civiltà italiana. E questo lo si dice non soltanto per quello che è il suo patrimonio artistico, no, lo si dice per quella che è la fisionomia stessa della città, per la sua aria, per la straordinaria bellezza della sua terra. Urbino è un paesaggio incantato, chi ha percorso soltanto una volta la strada rossa che porta a Fermignano per valli di una dolcezza indimenticabile o conosce la strada ducale che corre sul filo delle colline, parallela alla provinciale per Pesaro, sa che non sono menzogne, sa che non è retorica. C’è una Urbino che respira al centro del cuore d’Italia e che è rimasta intatta dai tempi dei suoi grandi pittori, a memoria di una dignità dello spirito che il nostro modo di vivere ha umiliato e infine perduto.
Commento parlato nel film dallo stesso titolo (Unitelefilm, 1965)
Ripubblicato in Carlo Bo, Discorsi rettorali, Urbino 1973
================================================================
URBINO PER PAOLO VOLPONI
Per ricordare Paolo Volponi a venticinque anni dalla sua morte, avvenuta il 23 agosto 1994, e per ricordare allo stesso tempo anche Giovina Jannello, sua moglie, morta il 18 gennaio 2018, che ha conservato il suo lascito letterario, la Fondazione Carlo e Marise Bo offre ai suoi lettori e visitatori un testo narrativo di Paolo Volponi profondamente legato alla città di Urbino, e due recensioni del suo romanzo Il sipario ducale, la prima di Giuliano Gramigna che introduce in maniera estensiva e concreta nella struttura del romanzo, e la seconda di Carlo Bo che presuppone, come era sua abitudine, la lettura del testo e lo interpreta collegandolo al rapporto essenziale di Paolo Volponi con la sua città, Urbino.
Inoltre indichiamo pubblicazioni e manifestazioni dedicate a Volponi da parte di studiosi urbinati e marchigiani che da sempre si sentono legati all’opera di questo grande urbinate.
PAOLO VOLPONI
Guerra di piume sopra la città
Ogni mattina appena il sole comincia a scaldare l’aria ha inizio la battaglia tra le cornacchie e i piccioni che in grandi, distinte moltitudini abitano la città. Quando il giorno è scuro, con una o due ore di ritardo, mentre si leva la temperatura diurna, comincia la stessa battaglia. In ogni caso lo spazio nel quale le due formazioni si incontrano è sempre lo stesso: il cielo davanti ai torricini, sopra il teatro, scosceso sul ghetto e sulle mura di Valbona, largo sul Mercatale, a vortice dentro le volte di Risciolo giù fino ai fossi. Più oltre verso l’Appennino e più alto in cima al monte delle vigne e alla Fortezza Albornoz, il cielo è fermo e vuoto e aspetta chi avrà vinto e prenderà il volo dominante. Chi perde slala in basso sulle case del Carmine e del borgo, si infila sotto le gronde delle strade o addirittura scende dentro i loggiati.
Le cornacchie iniziano la lotta buttandosi di slancio e stridendo dai vari ordini di cornici del Palazzo ducale, dai balconi nobili fra le due torri, dalle finestre aperte del giardino pensile e dalle murate più alte del castellare. I piccioni si muovono ad affrontarle con un volo pieno, ben disposto in una curva affilata, giungendo dalle file domestiche dei tetti più alti del centro della città e anche dai palazzi più autorevoli della piazza, dalla mole di San Francesco e dalle tettoie della Piazzetta delle Erbe. Un branco di piccioni viene giù dal monte, dagli orti dei maceri, dritto e rapido quasi in tuffo. Altri branchetti di piccioni accorrono dai tetti del Mercatale e di Ca’ Condi, presto raggiunti da altri, ancora più fitti e agitati, in crociera dalle campagne più vicine e dalle frazioni di Mazzaferro, Tufo, San Cipriano.
I piccioni cittadini intanto stanno facendo un altro giro per calcolare con maggiore esattezza il momento e il fronte dello scontro. Quelli in avanguardia dal Mercatale si alzano d’improvviso, come presi dal vento, a meno di dieci metri dalle mura lasciando scoperti e sorpresi gli stormi della campagna. Le cornacchie aspettano questi con un fronte teso tra il teatro e i torricini, alto e staccato da qualsiasi sporgenza in modo da consentire le più vertiginose acrobazie. Si infilzano o calano sciabolando con l’ala dentro i campagnoli battendoli prima ancora di colpirli. Questi non sanno dove ritirarsi: non vedono tettoie, né pagliai. Cercano scampo verso i neri alberi del Pincio, ma prima di poterli raggiungere subiscono una seconda ondata di colpi. Alcuni stramazzano sulla strada, altri a filo delle mura tra i sambuchi e le ortiche dell’orto detto dell’Abbondanza.
Le cornacchie si voltano allora contro i piccioni cittadini, disposte in due fila a diverse quote, ma entrambe ripiegate ad angolo nell’estremità di sinistra per intercettare anche la formazione di avversari in discesa dal monte. Ne segue lo scontro più vasto e più lungo: meno accanito del primo, ma più determinato e cruento. E mentre si sta annodando o lacerando vi piomba sopra la piccola tela dei piccioni del borgo che prima si erano impennati forse più per sfuggire l’impeto iniziale che per quella loro strategia. Così crollano anche alcune cornacchie; irate proprio come se fossero sorprese da uno stupido accidente. I piccioni cittadini appaiono tutti sconvolti e spiumacciati: si arruffano per difendersi e si spennano per ingannare il nemico. Si sottraggono brontolando e rotolando per raggiungere al più presto il tetto del teatro o le gronde delle stallacce. I piccioni del monte, ancora compatti e aguzzi malgrado le perdite, tentano un altro attacco, che mira a sorprendere le cornacchie dal ventre e dalla coda; ferire strisciando e scivolare via, sopra Risciolo tra le volte e le ripe degli scoli. Luoghi che le cornacchie aborriscono ed evitano con inderogabile cura. Non calano mai sotto il livello delle mura della città.
Adesso più nessuno combatte anche se nel cielo continua l’agitazione di molti contendenti. Si stanno riformando i branchi come per dare solennità e forza alle nuove formazioni e alle direzioni di ritirata. I piccioni di campagna si ritrovano tra gli alberi del Pincio e gli orti di Ca’ Fante. Da lì vedono i pagliai della strada rossa e di Ca’ Paciotto. I piccioni del monte volano basso intorno alle vigne per defilarsi lungo il Giro dei Debitori fino al monumento di Raffaello e alla chiesa degli Scalzi. I piccioni del Mercatale stanno tutti accalcati sul tetto rosso, come difeso da una cintura di fili di antenne, del commissariato di Polizia. Quelli cittadini si riassestano le penne risalendo in due colonne parallele il loggiato e Valbona per tornare in piazza, una a Palazzo Albani e l’altra, più numerosa, a San Francesco e sulla Piazza delle Erbe. Sanno già che a quell’ora gli studenti e i professori lasciano cadere infinite briciole di panini, brioches e pizzette.
La battaglia dura ogni volta non più di tre minuti, cinque se si conta dalla partenza dei piccioni dalla piazza fino al loro farvi ritorno. Sono pochi gli urbinati che assistono alle sue vicende con una certa frequenza e non tanti nemmeno quelli che la vedono per caso. Anzi i più la evitano deliberatamente perché la sentono come un evento estraneo e fastidioso; selvaggio, non civile. Non adatto a questi tempi, eppure brutto segno degli stessi. Gli urbinati parteggiano per i piccioni che sono cittadini da secoli: notabili dotti e istruiti, con collari di congregazione, abitudini sociali, circoli, residenze. Li vedono da sempre guardare con serietà e giudizio dagli scalini delle logge del collegio e di San Francesco il selciato della piazza, tutta la piazza, la gente, il tempo e proprio con reazioni umorali da cittadini.
Le cornacchie sono forestiere: sono entrate in città qualche anno dopo la guerra. Dapprima isolate, successivamente in piccoli branchi; a mano a mano sempre più numerose e prepotenti. Chi le conosceva sapeva che erano uccelli tipici del Sud più povero e trascurato. Oppure di valli anche alpine, ma strette e rocciose, con qualche pascolo e mandria. Molti ritengono che abbiano seguito i sardi che sono venuti con i loro greggi di pecore nei campi dei nostri poderi abbandonati. Altri dicono che tutta l’Italia si sta meridionalizzando. Altri che quegli uccelli prediligono le grandi regioni spopolate e incolte come quelle nostre collinari oggi. Altri ancora che crescono insieme con i mucchi di immondizia e di rifiuti. Qualcuno dice che sono una specie in espansione e che crescerà fino a dominare il mondo quale potrà restare in futuro.
Sono così intelligenti, organizzate ed efficienti che nessuno può batterle e contrastarle. Nessuno che con un fucile possa arrivare mai a tiro, sia in volo che a fermo, da poterle sparare con efficacia. Sembrano davvero di ferro e di meccanica: ali di latta, petto di ghisa, becchi e artigli di acciaio. Sembrano pezzi di vecchi o di nuovi motori combinati per una sorte animale. Ormai dominano Urbino, dove hanno scelto come residenza scrupolosamente il Palazzo ducale. Dominano il cielo e le correnti di tutto il territorio urbano ed agricolo; e li traversano con grandi voli alti e sicuri sempre secondo la stessa rotta. La mattina vanno a occupare tutti i campi lungo il Metauro o gli altipiani del Petralata e la sera tornano nella loro residenza dominante. Non vogliono nessuno intorno: né piccioni, né altri uccelli, né topi, né uomini. Non si capisce perché i piccioni vadano sostenere quella battaglia, intanto pensano gli urbinati. Esseri più intelligenti e progrediti avrebbero, secondo gli stessi cittadini, rinunciato da un pezzo.
“Corriere della Sera”, 29 gennaio 1984, poi in Cantonate di Urbino, Stibu, Urbania 1985, 21996, e in seguito in Paolo Volponi, Del naturale e dell’artificiale, a cura di Emanuele Zinato, il lavoro editoriale, Ancona 1999, pp.123-127
Giuliano Gramigna
Dietro il sipario la verità nascosta. Il nuovo romanzo di Paolo Volponi
L’elemento chiave del romanzo è lo schermo televisivo, un simbolo di quella storia ufficiale che manipola i fatti.
“Memoriale”, il primo libro di narrativa di Paolo Volponi, porta la data del 1962; “La macchina mondiale”, del ’65; poi un lungo intervallo fino a “Corporale” uscito nel ’74; e ora, a distanza di appena un anno, un nuovo romanzo, “Il sipario ducale”. Questo genere di reperti ha, s’intende, scarsa importanza ermeneutica e critica. Tuttavia la contiguità cronologica con “Corporale” può diventare un dato di lettura, collegando anche esteriormente il nuovo romanzo con il precedente (il vero collegamento avviene all’interno). Sebbene, in un colloquio con Lorenzo Mondo, Volponi abbia collocato alla radice del “Sipario ducale” un “risentimento verso la critica” e una sfida (“volete il romanzo facile, capite solo quello? Eccolo qua…”), il libro in realtà non rinnega per nulla “Corporale” con la sua magmaticità e i suoi tormentati e necessari sperimentalismi (per inciso, bisogna riconoscere che la prospettiva sia pur breve del tempo ha reso giustizia a “Corporale” che appare la proposta recente più coraggiosa e autentica di un testo insieme globale e disseminato”). Insomma: “Il sipario ducale” non è, a dispetto delle apparenze, né un romanzo tradizionale, cioè antisperimentale, né un romanzo semplice, cioè senza volume. La lettura che si tenterà qui sommariamente sarà diretta a difendere un’opera di vera forza, integrità, complessità anche contro il rischio di un “successo” malinteso, falsato.
Il teatro del “Sipario ducale” (e si vedrà che particolare pluralità di significati acquisti il termine “teatro”) è Urbino, su cui si proiettano le vicende di una coppia di anarchici reduci dalla guerra spagnola, Vivés Guardajal e il professor Gaspare Subissoni; e di un’altra coppia parallela, il giovanissimo conte Oddino Oddi-Semproni e il suo tirapiedi-autista pubblico Giocondo Giocondini. Il tempo storico è quello del dicembre del ’69 con la strage alla Banca dell’Agricoltura di Milano. E’ stato sottolineato che le strutture (apparenti) del racconto sono quelle di un romanzo “canonico” con i suoi bravi “personaggi” e luoghi identificabili, che le avventure di Subissoni-Vivés si alternano a quelle di Oddino-Giocondini, un capitolo per coppia, anche se verso la fine la ripartizione non è più rigorosamente rispettata. Che Subissoni rappresenta un altro di quegli emarginati, “diversi”, folli congeniali a Volponi (da Saluggia a Crocioni a Gerolamo Aspri): feroce oppositore dell’unità d’Italia come gaglioffa e fittizia imbracatura che ha spento nel Paese ogni reale libertà e intelligenza, soffocando le autonomie locali (i suoi testimoni sono Pisacane e Cattaneo) etc. La notizia delle bombe di Milano turba i due anarchici e specialmente Vivés, chiamata a ripensare tutto il proprio passato e futuro (“io sento che sto ricominciando o cominciando…”). Ma la morte di Vivés interrompe questo ripensamento e traumatizza all’estremo Subissoni, che tuttavia trova una ragione di continuare (o un transfert psicanaliticamente?) nell’assumersi la protezione di Dirce, dolce e inflessibile bimba-puttana campagnola, che Oddino voleva fagocitare nel suo “teatrino” nobiliare.
Ebbene: tutti questi dati o informazioni, a mio giudizio, sono ancora inessenziali al libro di Volponi. Essi trattengono il lettore alla periferia del testo, dove esso è più semplice e commerciabile, ossia non è ancora testo. Si vorrebbe invece indicare qui, sia pure grossolanamente come impone lo spazio, quali sono i condotti, le strade che conferiscono i sensi molteplici di questo “Sipario ducale”, cioè come esso produce la propria significanza; insomma individuare le “voci” che parlano nello spessore del libro.
La vera presenza dominante, il significante chiave del romanzo è lo schermo televisivo, il riquadro lattiginoso davanti al quale Oddino passa gran parte delle sue giornate e a cui gli stessi Subissoni e Vivés angosciati chiedono un senso, magari da contrastare, da negare. La TV è così la “Voce”, non solo in senso stretto, materiale, ma anche simbolico, a livello di rappresentazione letteraria simbolica, di quella Storia ufficiale che manipola i fatti, uccide, impone le colpevolezze, secondo la logica ottusa, caparbia, eterna del potere. Essa è dunque il Significante irresistibile di quella Unità italiana che Subissoni detesta. Questa voce-immagine ubiqua e mistificatrice, meccanizza la Storia e gli uomini e s’identifica, come una minaccia, con le bombe e la strage. Essa è la “comunicazione” di quella pseudo-storia che si serve delle bombe per affermarsi; è dunque, in questa sua “larghezza”, una delle invenzioni più affascinanti e originali del testo. La televisione, “occhio-mente di Ciclope”, si affianca e insieme si contrappone al “teatrino”: teatrino è (per Subissoni) l’Italia unitaria; teatrino è anche Urbino borghese e conformista: come tali, questi teatrini rientrano nella voce, nel “codice” della Storia delle stragi. Ma teatrino è pure il mondo chiuso di Oddino, dove egli si proietta idealmente le sue filmine gratificanti, di giovin signore potente in nuce; e lo è il corpo stesso di Subissoni (vedi pag.113) dove sussulta, ondeggia, crolla e si riprende una “diversità”.
In Vivés si manifesta, invece, il codice “doppio” della azione e dell’immobilità meditativa. I termini non sono affatto contrastanti. Vivés si prepara ad agire sulla storia (e lo farebbe se la morte non la cogliesse) e agisce effettivamente sul racconto, soprattutto attraverso la sua capacità di concentrazione, il suo “fermarsi” in una ragione insieme speculativa e civile, il suo voler sapere per operare. E’ dunque l’esatto opposto dei succubi della televisione ossia della Storia delle bombe; si pensi ai suoi quaderni, alle sue letture ostinate, allo spietato esame del proprio corpo etc. Quando il romanzo parla attraverso la voce (il codice) di Vivés, prevalgono le sequenze di carica preparatoria di riesame, di rievocazione critica. “Vivés continuò per almeno due ore a guardare la linea dalla quale il muro scendeva verso la finestra…”. Naturalmente l’immobilità qui non è abbandono o rinuncia ma equilibrio, condensazione di forze per l’azione. Vivés certo è elemento capitale, connotante del romanzo: ma non semplicemente perché arricchisca la galleria dei personaggi femminili volponiani con una nuova immagine dolce e fiera. In Vivés, oltretutto, si fondono e coesistono le due facce grottesca e tragica del libro.
“Grottesco” è, naturalmente, il codice che comprende la maggior parte, se non tutte le tirate, allocuzioni, uscite, pantomime di Subissoni: Una lettura come quella che si è cercato di suggerire, riesce a ristabilire nel suo giusto valore anche certi aspetti del libro che parrebbero rientrare negli schemi romanzeschi tradizionali. Si prenda per esempio il monologo di Subissoni nelle prime pagine: esso non è il vecchio monologo, il “trucco” espressivo attraverso il quale l’autore raggiunge il fine pratico di presentare ai lettori il suo protagonista, di somministrare loro tutto il carico di informazioni che ritiene necessario alla comprensione della storia. Vi esplode, né più né meno, uno dei discorsi che reggono il libro, la voce del delirio (calcolato), del paradosso polemico, della “violazione del normale” tanto cara a Volponi.
La voce della Storia delle bombe (in cui viene inglobata anche la marionetta Giocondo Giocondini, ilare servo pieno di macchinazioni e di stupidità); la voce degli automi; la voce della meditazione-azione: ecco alcuni dei livelli o sensi che si mescolano nella treccia del romanzo di Volponi e che ho cercato di separare per comodità di lettura. Dalla loro mescolanza nascono quegli effetti di deformazione mitico-fantastica che Volponi fa subire alla realtà storica e geografica senza mai abbandonarla per l’astrazione e senza mai tradire la sua ideologia civile. Per questo il libro ha una densità e insieme una trasparenza rarissima negli esempi di questi ultimi anni.
“Il Giorno”, 25 giugno 1975
CARLO BO
Il sipario ducale
Volponi è nato come poeta e nel campo della poesia ha ottenuto i suoi primi successi. Poi, quasi improvvisamente, è passato alla prosa e dal tempo del Memoriale (1962) la sua vocazione è quella del romanziere o, meglio, di inventore di favole moderne: La macchina mondiale del 1965, Corporale dell’anno scorso, e con ritmo accelerato, il libro di oggi, Il sipario ducale.
Il successo toccato al narratore ha in qualche modo appannato e fatto dimenticare la natura e la qualità del poeta, eppure se i suoi «romanzi» tengono, se corrispondono alle sottili argomentazioni positive dei suoi critici lo devono ancora alla poesia, al vigore delle ragioni poetiche che superano di molto l’architettura spesso incerta e arbitraria dei suoi racconti e compensano la mancanza dell’arte del comporre, secondo la lezione dei grandi narratori del secolo scorso. Ma c’è di più, la stessa carica morale e civile, oggi dichiaratamente politica, delle sue storie ha un precisa derivazione poetica.
È, dunque, nell’ambito della poesia che si muove e agisce lo spirito del romanziere, così come dalla poesia arriva ogni suo tentativo di collegare le sue ironie, le sue impazienze e quel tono di grande indignazione che lo porta ad assumere l’abito del riformatore e di chi sembra avere in mano le chiavi degli ultimi problemi, in particolare del dramma che da anni vive il nostro Paese.
Ma qui entriamo in un capitolo che lo stesso Volponi ha tenuto a illustrare direttamente in diverse interviste prima e subito dopo la pubblicazione del romanzo epperò vorrebbe dire – riprendendolo – ripetere cose generosamente affermate e sostenute con grande partecipazione e con una ombra di ingenuità. Volponi è una natura asseverativa e ciò che sente ha immediatamente il crisma dell’autorità e non c’è dubbio che per lui corrisponda al canone stesso della verità assoluta.
Questo carattere del suo discorso fra umano e politico lo ritroviamo nella descrizione dei suoi personaggi maggiori che sono la voce e la immagine delle sue passioni del momento ma si tratta pur sempre di un discorso poetico né varrebbe chiedergli dimostrazioni o soltanto giustificazioni, così come avremmo fatto con un narratore di altre proporzioni e di più ridotte ambizioni, attento piuttosto a provare il dato della verosimiglianza e il fenomeno più propriamente storico. No, alla fine d’ogni sua nuova navigazione l’impressione che lascia al lettore è quella di una forte personalità, di un tipo di uomo, stretto fra contraddizioni e apparenti equivoci di fondo, di qualcosa che per sua fortuna sfugge all’alchimia della letteratura e rientra nel dominio della baldanza poetica.
In parole povere, ciò che colpisce in Volponi e lo rende diverso dagli altri, anche dai suoi compagni di cordata è un certo suo spirito anarchicheggiante e che gli viene in primis dalle sue origini, dalla sua terra, dalla sua prima educazione, da un fondo bene accertabile di autonomia libertaria e – subito dopo – dalla consapevolezza poetica, da quella sua felice facoltà di trasferire tutto o quasi tutto sul terreno dell’invenzione non calcolata né controllata.
Il libro non si scosta, dunque, da questa condizione generale né deve ingannarci la facilità del dettato (soprattutto in rapporto agli altri romanzi e in modo particolarissimo a Corporale che resta fino ad oggi la maggior impresa del narratore). Non c’è dubbio che di tutto ciò che Volponi ha scritto questo resta il documento in apparenza più naturale. Come si usa dire, si ha la sensazione che nell’atto di scriverlo abbia voluto divertirsi e insieme divertire il consumatore di carta stampata.
Lo stesso stratagemma delle due storie parallele sembra dovuto alla preoccupazione di rendere più agevole il tono alto, il dato drammatico della vicenda che è quello degli anarchici Subissoni e Vivés. L’altra storia – quella dell’immaginario principe di Urbino e d’Italia, il contino Oddino Oddi-Semproni – costituisce, come è stato assai bene osservato, una gustosa variazione di timbro palazzeschiano a beneficio di un rapporto più importante e significativo, il quadro dell’Italia dopo il 12 dicembre 1969. Ma – lo ripetiamo – Volponi sente e vuol comunicare le sue dolorose sensazioni e non si prefigge mai di dimostrare qualcosa, non per nulla il suo discorso diventa più evidente quando lo presta ai suoi personaggi diversi, ai suoi picareschi e, nel nostro caso, quando lo mette in bocca al professor Gaspare Subissoni.
Non sarebbe difficile seguirlo nei suoi umori e nelle sue improvvise ribellioni e allora si vedrebbe come il Subissoni-Volponi o il Volponi-Subissoni sia piuttosto uno stato d’animo, un modo di vedere e sentire e partecipare la storia d’Italia, l’Italia dei «particolari», tradita, l’Italia dei Cattaneo e dei Leopardi. Ma è proprio questo a lasciare al romanzo tutta la sua libertà, è il discorso libero a consentirgli di strappare i risultati più notevoli: la figura di Vivés, la sua morte, i suoi funerali e il contrasto fra la figura del ribaldo Giocondini e quella della fidanzata Dirce e – inutile registrarlo – tutto quanto appartiene al registro autentico del Volponi poeta con le immagini di Urbino, la vita, le miserie, le piccole astuzie di quella segretissima provincia e infine il paesaggio con l’intero quadro delle sue mutazioni e delle sue stupende trasformazioni. Non so se lo scrittore se ne avrà a male, ma – a nostro gusto – è proprio questa minutaglia quotidiana, questo stupendo caleidoscopio di cose minime, insignificanti e che pure fanno la vita, a riscattare il libro dalle sue debolezze e dalla schematicità dell’impianto.
Volponi da molti anni non vive più a Urbino, ha corso il mondo, ne ha gustato le vittorie, ne ha studiato i meccanismi attraverso l’industria, la economia e lo spettacolo del potere ma il suo cuore o la parte migliore del suo cuore è rimasta sotto quel cielo. Non per nulla il suo libro più diretto, un libro che nel tumulto della rappresentazione è una confessione, anche là dove cede all’accusa e al risentimento, è tutto urbinate.
Per anni Volponi aveva girato intorno alla «piazza» che già uno storico illuminato, Fabio Cusin, aveva identificato con l’immagine grande dell’Italia, era rimasto nelle campagne che lo accompagnano verso il regno della poesia o si era limitato a delle rapide intrusioni, con Il sipario ducale il giuoco diventa più scoperto, la posta più alta. Volponi – nonostante il divertissement con le sue cadenze palazzeschiane o gaddiane o felliniane – sembra aver preso coscienza d’un fatto, che è venuto il momento di compromettersi, anche se per ora vince la favola con i suoi incantesimi.
Ma l’abbiamo detto, il discorso è tanto diretto da suonare personale, confessione, ma, come avveniva al tempo delle buone confessioni, ai pentimenti e alle contrizioni (se pure mascherate e contraffatte dallo spirito d’imprecazione), a questa che resta una testimonianza partecipata dovrebbe seguire un impegno diverso, grave e decisivo. Che è poi ciò che chiedono le vittime come Subissoni e Vivés nel mondo offeso e profanato e gli innocenti come Dirce. Ma passare dalla favola alla realtà non è una cosa da nulla. L’esortazione di Volponi è ancora e nonostante tutto un atto di poesia.
“Corriere della Sera”, 6 luglio 1975
———————————————-
Opere narrative poetiche di Paolo Volponi
Memoriale (1962)
La macchina Mondiale 1965
Corporale (1974)
Il sipario ducale 1975
Il pianeta irritabile (1978)
Il lanciatore di giavellotto (scritto tra 1950 e 1960, pubblicato 1981)
Le mosche del capitale 1989
La strada per Roma (scritto tra 1950 e 1960, pubblicato 1991)
Il leone e a volpe (con Francesco Leonetti) 1995
Il ramarro (1948)
L’antica moneta (1955)
Le porte dell’Appenino (1960)
Poesie e poemetti 1946-66 (1980)
Con testo a fronte. Poesie e poemetti (1986)
Poesie. 1946-1994 (2001)
Pubblicazioni e Manifestazioni su Paolo Volponi realizzate alla Fondazione Carlo e Marise Bo e all’Università di Urbino
Paolo Volponi, Poesie e poemetti 1946-66, a cura di Gualtiero De Santi, Einaudi, Torino 1980, 209 p. (di De Santi Note e Bibliografia)
Nell’opera di Paolo Volponi, in “istmi”, 15-16, 2004-2005, Tracce di vita letteraria, a cura di Eugenio De Signoribus, Enrico Capodaglio e Feliciano Paoli, Collaborazione redazionale: Biblioteca Comunale, Urbania (19 contributi)
Autori Vari, Il Cerchio. Omaggio a Paolo Volponi, a cura di Evelina De Signoribus, Associazione Culturale La Luna, in collaborazione con la rivista “istmi”, Grafiche Fioroni, Casette d’Ete (AP) 2005 (con 22 contributi, 3 di Volponi, 8 incisioni e 8 fotografie)
Annalinda Pasquali, Atlante del viaggiatore letterario. Dai testi di Paolo Volponi al territorio: le terre dei Montefeltro, Quattroventi, Urbino 2006
Dentro il paesaggio: poeti e natura, a cura di Salvatore Ritrovato, Archinto, Milano 2006 (La città ideale), 185 p.
Pianeta Volponi: Saggi Interventi Testimonianze: Giornate di Studio dedicate a Paolo Volponi (Urbino, Urbania, Cagli, 2-4 novembre 2004), a cura di Salvatore Ritrovato e Donatella Marchi, Metauro, Pesaro 2007, 237 p.
Salvatore Ritrovato, All’ombra della memoria: studi su Paolo Volponi, Metauro, Pesaro 2013, 120 p.; Metauro, Fano 2017, 150 p.
Volponi estremo, a cura di Salvatore Ritrovato, Tiziana Toracca, Emiliano Alessandroni, Metauro Edizioni, 2015, 517 p. (contiene 31 contributi, la maggior parte delle relazioni presentate al Convegno tenuto a Urbino nel 2014)
Urbino: la storia del Novecento con Carlo Bo, Paolo Volponi, Italo Mancini, Giancarlo De Carlo. Testo di Gastone Mosci, ritratti di Federica Minelli, UNILIT, Urbino 2015, 1 cartella, 4 p.
CARLO BO SU PAOLO VOLPONI
Il verbo di Volponi, Presentazione a Paolo Volponi, Il ramarro, Istituto Statale d’Arte, Urbino 1948, pp.7-8; poi in Carlo Bo, Aspettando il vento, Introduzione di Mario Luzi, Con sei disegni di Leonardo Castellani, L’Astrogallo, Ancona 1976, poi in Carlo Bo, Aspettando il vento , a cura di Galliano Crinella, Premio Nazionale Gentile da Fabriano, Fabriano 2011, pp.45-46
Non trascurare la poesia né l’attualità politica (su libri per le vacanze di P. Volponi… e altri), in “La Stampa”, 6 luglio 1962
La macchina mondiale, in “Corriere della Sera”, 1 maggio 1965
Quattro proposte per un confronto di generazioni: T. Landolfi, Paolo Volponi,”La macchina Mondiale”, A. M. Ortese e C. Monterosso in “L’Europeo”, a. XXI, n.22, 30 maggio 1965, p.95
Corporale, in “Corriere della Sera”, 9 settembre 1973
Il sipario ducale, in “Corriere della Sera”, 6 luglio 1975
Paolo Volponi notturno. Vent’anni di diario poetico, in “Corriere della Sera”, 4 giugno 1986
Il mondo di Volponi divorato dal potere. Nuova satira nelle “Mosche del capitale”, in “Corriere della Sera”, 6 maggio 1989
Canetti, Volponi e Tofanelli, addio a tre grandi della letteratura, in “Gente”, 26 settembre 1994
Biblioteca della Fondazione Carlo e Marise Bo
Sono disponibili 48 titoli di opere di Paolo Volponi e 57 pubblicazioni di autori diversi su Paolo Volponi
Documenti di Paolo Volponi conservati nell’Archivio Urbinate presso la Fondazione Carlo e Marise Bo per la Letteratura europea moderna e contemporanea, Urbino, Palazzo Passionei Paciotti, Via Valerio 9
OPERE NARRATIVE
Memoriale (1962) (Testo dattiloscritto)
La macchina Mondiale (1965) (Testo dattiloscritto, fogli singoli manoscritti)
Corporale (1974) (Testo dattiloscritto, alcune parti con testo manoscritto)
Il lanciatore di giavellotto (scritto tra 1950 e 1960, pubblicato 1981) (Testo dattiloscritto)
La ricchezza (= La strada per Roma) (1965) (Testo dattiloscritto)
La strada per Roma (scritto tra 1950 e 1960, pubblicato 1991) Testo manoscritto e testo dattiloscritto)
Le mosche del capitale (1989) (Testo manoscritto, Testo dattiloscritto, Bozze del testo)
Il leone e a volpe (con Francesco Leonetti) (1995) (Testo dattiloscritto con 2 lettere di Francesco Leonetti)
================================================================
Addio a Jean Starobinski, il medico principe della critica letteraria
Il grande studioso svizzero è morto a Morges all’età di 98 anni.
Figura unica del panorama critico internazionale, è stato insignito della laurea “honoris causa” dalle più prestigiose università del mondo
Si stava avvicinando a compiere il secolo, Jean Starobinski. È morto a Ginevra, dove era nato nel 1920, e lì si era formato, saldando i due interessi essenziali della sua vita: la letteratura e la medicina. Si era specializzato in psichiatria, e la sua indagine prolungata nel territorio della psiche si avvaleva di una cassetta degli attrezzi da umanista-scienziato.
Uno specialista della civiltà occidentale, un ascoltatore dei testi letterari capace di esplorarne i “temi” come motivi appunto musicali, melodie. Dà al critico il compito ambiziosissimo – e destinato, come lui stesso diceva, a restare incompiuto – di riconnettere un’opera ai motivi meno visibili di un’immaginazione/immaginario, di cogliere “tutti i rapporti” che essa ha “col mondo, con la storia e con l’attività di un’intera epoca”.
Lo spazio dell’universo, lo spazio della storia, lo spazio dell’interiorità: Starobinski cerca le cuciture, i richiami, prova a stanare il momento generativo di una “poetica”, ne affronta la turbolenza, tanto più forte, radicale, quando realtà e irrealtà entrano in conflitto. Cercava per questo nel “furor”, nella follia, nell’estremo dell’incubo e del delirio la rivelazione di una verità notturna: dai Greci a Shakespeare a Hoffmann, da Rousseau a Flaubert, Starobinski è il medico col termometro, quello che misura la febbre di autori e personaggi, la “scala delle temperature”.
Tra la fine degli anni Quaranta e la fine degli anni Cinquanta, quando era stato prima interno in una clinica universitaria a Ginevra e poi in ospedale psichiatrico vicino a Losanna, aveva deciso di studiare, da medico e da letterato, la “storia millenaria della malinconia e della sua cura”. Alternava radioscopie a letture appassionate di Montaigne, lezioni di neurologia a scambi quotidiani con Leo Spitzer.
“Vengo spesso considerato un medico apostata – ha scritto nel 2012, raccogliendo i testi dedicati su un arco di mezzo secolo ‘all’inchiostro della malinconia’ – passato alla critica e alla storia letteraria. A dire il vero, i miei lavori erano frammisti”. E con “disinvolta pacatezza” – il “tono” di Starobinski , per come l’ha perfettamente colto Yves Bonnefoy – il grande ginevrino insisteva a indagare nel disordine dell’anima. Quando, in un piccolo bellissimo libro su Baudelaire, Starobinski legge La Malinconia allo specchio, da dialogare i versi dei Fiori del male con le luci e le ombre di una tela di La Tour, con lo spettro angosciante che una “Maddalena penitente” pare contemplare nel buio appena rischierato da due candele.
Cerca sempre di fare la storia dei sentimenti, ovvero l’avventurosa “storia delle parole tramite cui l’emozione si è enunciata”. Così, le parole-chiave di Starobinski – in una ipotetica mappa lessicale che ci dice molto di lui – sono “malinconia”, “libertà”, “ragione”, “sogno”, “trasparenza”, “azione-reazione”, e “dono”.
L’umanista tenace, l’elegantissimo conversatore-ascoltatore, (“La parola è per metà di colui che parla e per metà di colui che ascolta” ripeteva col suo Montaigne), ha creduto fino in fondo al lavoro sulle idee e sulla letteratura come “festa della ragione critica”, all’interrogazione costante del rapporto fra etica e estetica, allo sforzo faticosissimo della comprensione che approda a un giudizio.
Se l’arte della critica è dialettica, è relazione, può tradursi – ci dice Starobinski – in un esercizio morale utile anche nel vivere quotidiano. “Ciascun critico come ciascun individuo – spiegava a Franco Marcoaldi su Repubblica qualche anno fa – ha ovviamente una relazione particolare e personale con il mondo, ma quando legge deve essere capace di mettersi in posizione di ascolto rispetto a mondi diversi dal suo. È quanto cerco di fare da una vita, anche se non sono affatto sicuro che il mio sguardo e il mio grado di ascolto siano sufficientemente ampi…”.
Paolo di Paolo, “La Repubblica”, 7 marzo 2019
Jean Starobinski
Il 4 marzo 2019 è scomparso a 98 anni Jean Starobinski, l’eminente critico letterario e docente di letteratura francese a Baltimora, a Ginevra e Basilea, medico specializzato in psichiatria, importante esploratore del mondo della malinconia.
L’Università di Urbino nel 1995 gli aveva conferito la laurea honoris causa in Lingue e letterature straniere.
Riportiamo la relazione di Giovanni Bogliolo, allora Preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Urbino, all’occasione della Laurea honoris causa in Lingue e letterature straniere a Jean Starobinski il 9 maggio 1995:
L’ampiezza, la varietà e l’importanza dei lavori di Jean Starobinski lo collocano tra le figure più eminenti del pensiero contemporaneo. La sua formazione interdisciplinare gli fa prediligere autori e linee di pensiero che si muovono in molteplici direzioni e si volgono a stabilire correlazioni, intrecci e percorsi laterali, senza mai azzardare commistioni laboriose o indulgere a semplicistici eclettismi, ma mantenendosi sempre in una linea di sostanziale fedeltà ai presupposti critici e metodologici che trasparivano già nei suoi primi lavori e soprattutto in quelli capitali rappresentati dalle sue due tesi di dottorato, in lettere e in medicina: Jean-Jacques Rousseau. La transparence et l’obstacle (1957) e Histoire du traitement de la mélancolie des origines à 1900 (1960). La sua concezione della critica come attività recettiva e come partecipazione simpatetica o come ricerca della propria attraverso l’altrui spiritualità, se è retaggio del magistero intellettuale e morale di Marcel Raymond e risente di quella temperie culturale che ha potuto accreditare l’ipotesi di una «École de Genève», mostra subito una sua imperiosa originalità. Anziché soffermarsi sulle forme, Srarobinski tenta di eluderle con una complessa e paziente strategia. Egli concepisce la «relazione critica» come inesausto esercizio del proprio «diritto di sguardo». Centrale per Montesquieu, a cui il critico ha dedicato uno dei suoi primi lavori, lo sguardo, ovvero quella capacità di scoprire attraverso la diversità dei fenomeni l’universalità della ragione, diventa capitale per la sua più personale elaborazione del «senso della critica». Legame vivente tra la persona e il mondo, tra l’io e gli altri, lo sguardo è dunque al centro della riflessione di chi, come il critico, ha il compito di vedere nitidamente, panoramicamente, non senza la lenta decifrazione di una paziente lettura ravvicinata, per situarsi in relazione con l’opera e di riconoscerne l’alterità e l’indipendenza, la sua prossimità e la sua distanza. Risultato di questa vigile lettura dei «sentieri segreti, ma obiettivi, dell’opera«, i due volumi L’œil vivant /(1961) e La relation critique (1970).
Lo studio della fenomenologia dello sguardo nei vari scrittori rimane, per Starobinski, la condizione indispensabile per scoprire la loro più profonda condizione esistenziale; obiettivo dell’indagine critica, di conseguenza, e, attraverso il testo, la scoperta delle più intime ragioni espressive, delle motivazioni profonde che rendono l’opera necessaria per il suo autore e affascinante per il lettore. La zona entro la quale si muove il suo discorso critico è neutra: non mira né alla totalità né all’intimità: né la sola vertigine della distanza di una visione à plomb né l’osmosi dell’intuizione identificante, bensì la ricerca di una verità che consiste nel movimento che va dall’una all’altra. Subire il fascino del testo sarà allora scoprirne la dimensione profonda, il senso secondo, il più lontano che riconduce al più vicino: le parole stesse ove il «senso elegge la propria dimora» (come se il linguaggio poetico risultasse essere un discorso di copertura, sotto cui si cela un messaggio: argomento questo, di Les mots sous les mots, uno studio sugli anagrammi di Saussure condotto da Starobinski nel 1971).
Montaigne en mouvement, del ’82,che raccoglie gli scritti degli anni ’56-’68 intornoai concetti di être e paraître, la già citata tesi su Jean-Jacques Rousseau. La trasparence et l’obstacle, ripresa nel ’71, si interrogano sugli esiti in un certo senso complementari del pensiero di due scrittori. L’analisi lucida, intima della loro opera, conduce Starobinski a leggere, nel primo, l’accettazione dell’apparenza come costitutiva e l’affermazione della sua legittimità, nel secondo, la nostalgia della trasparenza originaria, la rassegnazione passiva alla separazione delle coscienze: due percorsi il cui movimento presuppone comunque uno «sguardo» sul mondo che solo se dimentico di sé può lasciarsi interrogare, «sorprendere», quindi rispondere. Tutto al contrario nell’esperienza del malinconico: al centro dell’interesse di Starobinski fin dalla tesi di dottorato di medicina e argomento delle sue lezioni al Collège de France dell’87-’88, la malinconia, che dopo Panofsky e Saxl il critico ha contribuito a conservare al centro dell’attenzione degli storici dell’arte e della letteratura, è oggetto di analisi in Trois fureurs (1974), e in La mélancolie au miroir. Trois lectures de Baudelaire (1990), studi in cui sono messi a confronto testi di poeti e di teorici della letteratura con un certo numero di rappresentazioni pittoriche. Inseparabile dall’idea che nella cultura occidentale, e per secoli, i poeti si facevano della loro stessa condizione, la malinconia nella sua stretta relazione con la riflessione filosofica è ancora tema e argomento dell’annunciato L’encre de la mélancolie.
L’invention de la liberté (1964), 17889: les Emblèmes de la raison (1973), il più recente Le remède dans le mal. Critique et légitimation de l’artifice à l’âge des Lumières (1989) e l’atteso Diderot: un diable de ramage sono saggi che si muovono nell’ambito dello studio dell’evoluzione delle idee e delle arti e che si ricollegano ancora una volta al campo della medicina. La nozione di crisi, che implica un passaggio e un’alternativa, contemporaneamente il male e il processo che decide, permettono allo studioso di interrogarsi sul limite tra barbarie e civiltà, tra conversione e caduta, su quel sogno di rigenerazione nel trionfo della luce della Ragione e nella chiarezza dell’intelligenza che caratterizza immagini, miti e opere del Settecento francese.
Claude Garache, dell’88, Table d’orientation dell’89, con Diderot dans l’espace des peintres (1991) e Largesse (1991), queast’ultimo concepito come catalogo di una esposizione al Museo del Louvre, sono le testimonianze più recenti della eclettica ma orientata visione del critico, che, come già nel lontano Portrait de l’artiste en saltimbanque (1973), non cessa di interrogarsi a tutti i possibili livelli e da sempre sosperso nel fragile equilibrio tra il volo e la caduta, tra il ripiegamento chino su di sé e l’elargizione, sorridente, del dono.
================================================================
Per il 25 gennaio 2019
Il 25 gennaio 2019 ricorre il centonono compleanno di Carlo Bo che ha voluto fondare questa Fondazione intestata a se stesso e a sua moglie, la scrittrice Marise Ferro, lasciandovi tutta la sua immensa biblioteca. Ci ricordiamo di lui con questo suo testo, scritto nel 1949, pochi anni dopo la fine della spaventosa seconda guerra mondiale, un testo che sembra scritto per la nostra attuale situazione, tesa da tanti contrasti nazionali e internazionali.
CARLO BO, Una voce da Springfield
Da Springfield negli Stati Uniti ci giunge una voce con molto ritardo ma è sempre tempo per ascoltare il segno della verità. È la voce di un vescovo e mi raccomando di insistere su questi due dati, è la voce di un vescovo americano: il suo messaggio è, dunque, doppiamente carico di un senso attuale, di una forza a cui bisogna rispondere subito.
Ci dice quel vescovo:
«Il problema bruciante per milioni di uomini del nostro tempo di disperati non è già di sapere se i dogmi cristiani siano o no accettabili. Ma è questo il problema: il vero cristianesimo può risolvere i conflitti sociali, economici e morali del nostro tempo?
Gli uomini d’oggi non sono attirati verso Cristo da dissertazioni teologiche che nascondono la questione essenziale: il vero cristianesimo può essere efficace? Gesù Cristo non parlava per sillogismi. Andava fra i poveri, i malati, con compassione e con comprensione, attirandoli a Sé con la dolcezza della sua carità»
Sono parole esatte e che, se esaminate con sincerità e con libertà di spirito, rispondono alle questioni che tengono i nostri giorni. Non c’è pace, si parla soltanto di pace, le sedute dell’ONU a Parigi sono finite nel più desolante dei fallimenti, tutti si preparano alla guerra protestando il più sincero desiderio di volere salvare questa nostra civiltà che, a cuor leggero, definiscono «cristiana». Ed ecco che il vescovo di Springfield ci soccorre anche a questo proposito:
«Smascheriamo gli ipocriti. Rifiutiamo, per esempio, il nome di cristiani a quei governanti che con la loro politica omicida di potenza e con l’accumulare stocks di munizioni contraddicono la beatitudine di Cristo: «Beati gli umili perché possiederanno il mondo».
Sappiamo che i capitalisti nevrastenici della proprietà che accumulano ricchezze eccessive mentre i loro fratelli muoiono di fame non meritano di essere uniti a Colui che ha detto: «Beati i poveri di spirito perché il regno dei Cieli è il loro». Né chiamiamo cristiani i diplomatici e i partiti politici rappresentati da loro nelle Assemblee di Nazioni che mentre parlano di pace preparano la prossima guerra con il più grande spregio dell’affermazione del Maestro: «Beati quelli che hanno il cuore puro, perché vedranno Dio».
Se i politici bacati, i capitalisti avari, i preti che accettano i compromessi, i superficiali «pilastri della società», gli educatori materialisti rifiutano di prendere il loro posto in difesa del cristianesimo, allora, in nome di Dio, smettiamo di chiamarli cristiani.
Il mondo ha bisogno della carità di Cristo, è la carità di Cristo che è la misura del cristianesimo di un uomo…Non ha forse detto: «Il segno per cui tutti gli uomini vi riconosceranno come miei discepoli sarà l’amore che avrete gli uni per gli altri?» Ristabiliamo questa carità nel cristianesimo perché è in questa sola virtù che vive il principio vivificatore, il vinculum perfectionis che raccoglierà tutti gli uomini nelle braccia della Chiesa di Cristo.
La questione è ridotta ormai ai suoi motivi essenziali: non si può aspettare la salvezza dai politici, non c’è una misura ridotta di fede che sostenga l’umanità in questo momento particolare, il campo è tenuto da pochi padroni assoluti della forza, il resto è dominato dalla miseria, dalla disperazione, dall’abbandono. Gli uomini non devono più cercare fuori di loro la ragione della speranza, se vogliono reagire al terrore del male devono cercare l’unica forza probabile nel loro cuore. Non serve illudersi con gli aggettivi, non serve nascondere il giuoco della politica sotto il mantello di una fede protestata come simbolo di guerra. E d’altra parte, chi saprebbe dire con precisione dove sono i veri cristiani? Dalla parte di chi alza questa bandiera per difendere il privilegio, l’abitudine, la pigrizia spirituale o dalla parte di chi è costretto dalla miseria, dal continuo disinganno, da una lunga storia di offese ad alzare il vessillo del nemico e a ripudiare l’ordine antico della prima fede?
Si aggiunga ancora che in un mondo perduto sotto la violenza di opposti fanatismi è difficilissimo, se non impossibile, discernere con esattezza la natura del rimedio. Nessuno crede più alle parole, da troppi anni siamo abituati al loro abuso, da troppi anni assistiamo ad una vergognosa speculazione. L’uomo non ha più tempo per sapere chi ha ragione, aspetta soltanto di vedere chi farà qualcosa per lui, chi arriverà primo in questa strada della carità. La stessa esperienza della guerra – un’esperienza che per la sua mostruosità ci sembrava fissa nell’eterno – è appena un ricordo, noi siamo così stanchi che non sopportiamo più neppure il modo della memoria. A questo punto non credo che si possa più andare avanti, anzi si è cominciato a giuocare con le carte scoperte: vuol dire che a un certo momento gli errori saranno un muro insuperabile e soltanto allora le parole ricominceranno a contare veramente. Non si è cristiani difendendo una immagine sterile di noi stessi, si è cristiani facendo qualche cosa. E qui siamo di fronte a una risposta abbastanza facile: si fa realmente qualcosa? Si lotta veramente per combattere l’ingiustizia oppure si continua ad abusare delle parole? Non basta scendere in guerra con dei pretesti, con dei sentimenti, ci vogliono delle armi e finora le uniche armi utili ci sembrano queste del vescovo di Springfield. Il resto è politica e non conta.
19 dicembre 1948
(da Carlo Bo, Letteratura come vita. Antologia critica, a cura di Sergio Pautasso, Rizzoli, Milano 1994, pp.1264-1266)
================================================================
25 gennaio 2018
Nel giorno del compleanno di Carlo Bo
giovedì, 25 gennaio 2018, alle ore 14.00
su su Radio 3, “Wikiradio”,
andrà in onda
un Ritratto di Carlo Bo
curato da Massimo Raffaeli
Per ricordare il compleanno di Carlo Bo, il 25 gennaio 1911, riportiamo l’Intervista di Giulio Galetto a Carlo Bo del 18 giugno 1995 a Verona in occasione di un convegno in memoria di Gino Barbieri, economista e storico, morto nel 1989. L’intervista è stata pubblicata su “L’ Arena” di Verona.
Solo la poesia ci ha salvato
“La letteratura del Novecento, lo specchio dei nostri giorni bui”
Il senatore (no: in questa occasione ci sembra più consono dire il professore) Carlo Bo esce dalla sala affrescata di Palazzo Giuliari, a Verona, intitolata ora a Gino Barbieri: lì il prof. Bo ha tenuto la prolusione appunto al “Convegno in memoria di Gino Barbieri”: una commemorazione dell’insigne studioso legnaghese di storia economica nella quale sono risuonati anche echi di autobiografia culturale: la sfiducia di Bo nei confronti della storia intesa come progresso (la storia che era studiata dall’amico Gino Barbieri), il segno diverso (pessimistico) del suo cristianesimo rispetto a quello ottimisticamente attivo della fede dell’amico. Sono, questi, segni che siglano fortemente da sempre, l’appassionata idea che Bo ha della «letteratura come vita»: un’idea alta, diciamo, della letteratura tanto quanto ¨alta la temperatura di una vita che avverte la ferita, la caduta e, nella caduta l’esigenza di “continuare ad attendere con dignità , con coscienza una notizia che ci superi, che ci soddisfi” (sono parole che si leggono nel testo della relazione che Bo lesse al «Quinto convegno degli Scrittori Cattolici» tenutosi a San Miniato nel 1938).
mentre il secolo si chiude e di letteratura si parla (molto), ma spesso come di qualcosa di decaduto, di spento (è recente, fra l’altro, il giudizio di “annata letteraria grigia” emesso dalla giuria del Campiello), che cosa dobbiamo pensare della formula 2alta” che lei coniò 57 anni fa, appunto “letteratura come vita”?
Credo che per letteratura d’oggi si possa parlare di ricapitolazione più che di viva creatività. Allora, negli anni Trenta, cioè¨ in un tempo in cui tante cose della realtà che ci circondava non potevano essere da noi accettate, letteratura come vita significava una passione per ciò che sentivamo più vivo e vero dentro di noi, per i nodi ideali del nostro spirito, una ammirazione per certe figure di scrittori che forse tendevamo anche a idealizzare, ma dalle quali ricavavamo messaggi insostituibili. Quell’amore della letteratura è rimasto, ma il panorama letterario che ci circonda mi sembra meno appassionante. Certo, io ho anche corretto col tempo la formula di letteratura come vita, l’eccesso di “interiorità” che essa forse sottintendeva: la realtà ha un peso, occorre che la parola colga questo peso”.
Per quell’ideale di letteratura come vita che coincise con la stagione ermetica si parlò di “assenza”. Lei ha detto che l’assenza era un modo di vincere un tempo storico buio in vista di una “certezza”, di un “ordine morale”. L’assenza può essere un’arma anche nel tempo buio, diversamente buio, di oggi?
“E’ difficile rispondere, è particolarissima la valenza che allora assumeva la dimensione di “assenza”, un modo non vile di rifiutare quel tempo. Certo io credo che i tempi siano sempre bui e che oggi sia ancora più buio di ieri o dell’altroieri.
In una intervista recente lei ha detto che il secolo che finisce le sembra fatto di fallimenti, di macerie, di presunzioni. E’ un giudizio assoluto o ha visto giusto Giuliano Gramigna supponendo che il suo sia stato uno “scoppio di pessimismo pascaliano” e “una specie di sazietà del leggere?
“L’interpretazione di Gramigna è riduttiva, perchè considera il mio giudizio solo in relazione alla letteratura. Io mi riferivo anche alla società , alla realtà nei suoi vari spessori; e il mio pessimismo su tutto questo è una convinzione radicata. Anche la mia fede cristiana vive dentro questo pessimismo”.
Dunque per lei continua ad essere vero quello che affermava nel ’45 rispondendo a Vittorini, che nel numero inaugurale di «Politecnico» lamentava la sconfitta della cultura occidentale nella quale aveva gran parte il cristianesimo. Lei rispondeva che “Cristo non è cultura”, cioè¨ che la fede vive nella umanità in modo radicalmente “altro” rispetto alla cultura e ai suoi veri o supposti effetti benefici.
“Certo, continuo a credere che Cristo non è cultura, non è semplicemente cultura. Vittorini credeva illuministicamente alle “magnifiche sorti e progressive”; io penso che la storia sia fatta sempre di conquiste e disfatte: è dall’interno di questa oscura realtà che si apre la fede per me”.
Che cosa pensa della realtà letteraria odierna della Francia, della Spagna, le cui letterature, soprattutto novecentesche, lei ha amato e ha fatto amare a molti di noi?
“Anche qui una risposta è difficile; sicuramente io vedo, per restare alla Francia, che i nomi di Gide, di Claudel, di Mauriac non sono stati superati; e allora anche qui, come dicevo prima, ho l’impressione che questi siano essenzialmente anni di ricapitolazione”.
Ricapitolando, allora, potrebbe indicare nomi o tendenze o settori del Novecento letterario da salvare?
“Lasciando stare il gioco dei nomi, direi che le cose migliori, quelle appunto da salvare, sono nella poesia piuttosto che nella prosa (a livello europeo, non solo italiano); la ricerca della poesia è una ricerca di verità più profonde, per questo credo che le parole della poesia siano soprattutto quelle che dobbiamo salvare”
In questa funzione di salvare e far conoscere le cose valide della cultura crede che i media, la televisione soprattutto, possano avere qualche funzione positiva?
“Si, fra tanto che passa attraverso la televisione, anche qualche cosa di positivo si salverà; però domina la confusione, il sovrapporsi caotico dei messaggi. Per questo lo strapotere della televisione, di cui tanto si parla, va guardato con sospetto”.
Siamo partiti dal binomio letteratura e vita, abbiamo parlato forse di letteratura più che di vita. La vita, la vita di oggi in Italia, in generale: come la vede (magari pensando che siamo a Verona, in una città che, per certe tragiche cronache aventi per protagonisti i giovani, ha fatto parlare di “sindrome veronese”
“Gli ideali” che vengono proposti sono deleteri: la ricchezza, il guadagno, il successo facile. Domina la tendenza a ignorare i valori della interiorità, non si è più capaci di ascoltare il “Dio nascosto” che è in noi”.
Amarezza, dunque, sulla generale realtà di oggi. E quel settore della realtà forse timone o specchio, che è la politica?
A questa domanda il viso del senatore si atteggia a un sorriso che ci sembra significhi la ovvietà di un giudizio che non può essere entusiasta e, insieme, il ritegno o il poco gusto che egli prova ad esprimerlo, quel giudizio. Poi dice:
“Mi sembra ci sia un vuoto di fondo sul quale cresce la chiacchera, l’esagerazione, l’ enfasi, la spettacolarizzazione”.
Quest’ultima risposta è breve, ma eloquente sulla assoluta disaffezione di Carlo Bo nei confronti di qualche cosa che è diventato, troppo spesso, vuoto rituale. Bo, che non nega la sua presenza alle cerimonie, ai riti, ci insegna proprio a fuggire il pericolo della retorica vuota in agguato dietri i riti. Ha saputo trasformare la commemorazione di Gino Barbieri in un colloquio col “Dio nascosto” della sua e altrui coscienza (e così ¬ possiamo dire che era stato un mese fa, su un territorio diverso – quello del suo lavoro di critico – in una commemorazione, tenuta a Feltre, di Dino Buzzati). Gliela esprimiamo questa nostra ammirazione per la sua capacità di dare spessore serio alle cerimonie: lui risponde:
“Le cerimonie sono cose buone: basta farle bene”.
================================================================
21 luglio 2017
Carlo Bo è morto a Genova il 21 luglio 2001, in mezzo alle turbolenti giornate del G8 che si è svolto nella città ligure dal 20 al 22 luglio 2001, duramente contestato da vari movimenti contrari alla riunione, contestazione che si è trasformata in violenti scontri tra manifestanti e forze di polizia. Anche l’ospedale in cui stava morendo Carlo Bo è stato toccato dalle agitazioni.
Carlo Bo ha destinato la sua grande biblioteca alla Fondazione Carlo e Marise Bo, creata il 3 febbraio 2000 quando lui era ancora vivo. Seconda la sua volontà questa biblioteca doveva conservare ciò che lui aveva raccolto durante la sua lunga vita, avrebbe però anche dovuto crescere in coerenza alla sua composizione originaria concentrata in primo luogo sulle letterature e culture dell’Europa moderna e contemporanea e le letterature nate in seguito e sviluppatesi nel nord e nel sud del continente americano. Carlo Bo voleva che questa biblioteca fosse a disposizione dei ricercatori e degli studiosi, ma soprattutto degli studenti della sua Università che aveva guidato per tanti anni. Il modo migliore di ricordarlo è frequentare questa ricca biblioteca e passarvi delle ore per leggere le opere che a lui erano state così care e fare delle ricerche sugli autori presi in considerazione anche da lui.
======================================================================================================================================
25 gennaio 2017
La Fondazione Carlo e Marise Bo desidera ricordare che Carlo Bo il 25 gennaio 1911 è nato a Sestri Levante. Per richiamare alla memoria la sua figura sono stati scelti due articoli, usciti nel 1991 per il suo ottantesimo compleanno, che presentano la figura dello studioso, del Rettore dell’Università di Urbino, del viaggiatore, del personaggio sempre in cerca dell’essenziale, della verità.
Cesare De Michelis (*1943), italianista e importante editore, descrive su “Il Gazzettino” del 25 gennaio 1991 la figura del grande studioso, Cesare Garboli (1928-2004), critico letterario, editore e scrittore, su “La Repubblica”del 12 gennaio 1991parla dell’influsso che lo studioso e critico letterario Carlo Bo ha esercitato sulla sua formazione e racconta dell’immagine che si è fatta di lui che di persona ha incontrato una sola volta nella sua vita.

